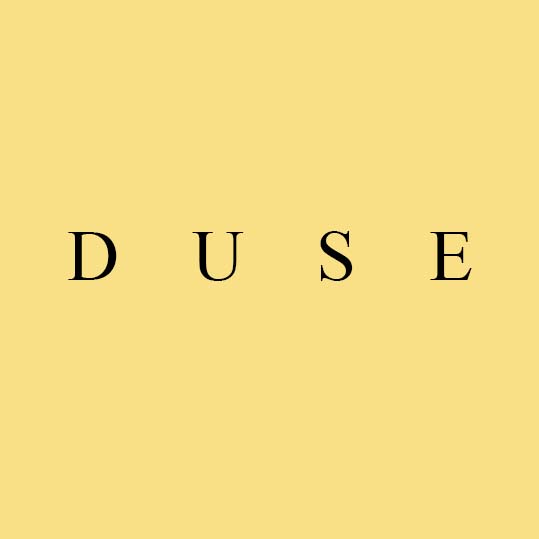
Spiazzante, per prima cosa, la mancanza di porsi, o la scelta di non porsi, il problema voce.
E della vocalità, quindi, che ci si aspetta da una proposta ambientata e vissuta da personaggi che hanno ragione di esistere, come il film sostiene per tutto il suo tempo, solo in dimensione ed ambito teatrale.
Un po’ come vedere la storia di Barrault in versione anchilosato.
Cresciuti nel silenzio della Duse su suggerimenti di sue vocalità straordinarie e dizioni appartenenti al mito, assistiamo all’esclusione della questione. In una dizione impossibile che già non permetterebbe un passo fuori da ciò che non fosse strettamente autobiografico-autoreferenziale,
in una scansione che raramente permette di capire, ci si snoda la presenza di una Duse che brilla nell’assenza assoluta dell’elemento all’epoca centrale, che ti permetteva di sussurrare all’orecchio della piccionaia le confessioni sibilate; che gli altri in scena si doveva supporre non sentissero, gli a parte a volte velati proposti come passi di un minuetto, esitazioni, del tutto confidenziali, sottili e insieme arrivanti, affidati comprensibili allo spazio, piccolo a volte, altre volte ferocemente vorace tra il palcoscenico e la platea, i palchi, i loggioni, i paradisi, dei teatri.
Quindi Duse, che i Savinio ci liquidavano con poca simpatia come la dolorosa, che la pochissima iconografia ci dava con sguardi obliqui in angolo d’occhio nell’innalzare i sopraccigli e mento al cielo, e che la storia ci ha finora regalato come la modernissima ammodernatrice dell’Arte Teatrale, ‘La Voce! Aveste sentito la Voce!’, qua è una figura-pretesto dall’occhio perennemente umido per raccontarci altro, poco di lei – come vorrebbe un teatro-laboratorio sperimentale e di ricerca quanto la sua strada percorsa – e un docu-film sull’altro grande ammodernamento piovutole come a tutti in capo, presto strisciante negli ultimi tre quarti della pellicola, questa volta social-antropologico-politico-tragico-farsesco che fu il Fascismo. Che vediamo prenderla per le mele, ignara, mentre poverina si invade di sé, arretrata, invasata, laddove la grande contemporanea Bernhardt, italianamente sempre voluta più baraccona della nostra ligia, geniale, essenziale e precisa nel sorprendere divina, qua ci fa un figurone di illuminata – eh già, ma lei veniva da Cartesio – davanti a una nostra esaltata saltata di slancio, come l’ostacolo da un cavallo che non si accorga di aver saltato, dalla tragedia del 14-18, della quale viene messa sull’avviso, in una scena rimbrotto-bada-bada dalla Sarah mondiale dopo di che, in una sorta di ‘Com’è vero, Signora Mia!’, si abbandona all’ebrezza dell’egalité-modernité. Proprio come avrebbe detto Wanda Osiris intervistata dieci anni dopo la sua ultima chiusura di sipario: ‘il teatro che farei oggiiiii? dovrebbe essere roooomantico”, e giù volute tracciate in aria con la punta degli indici, “e al tempo stesso mooooderno!”, e via due belle secche grandi parentesi quadre tracciate sempre in aria, sempre a forza di indici rapidograph. E il film continua, e la va e la va, senza lasciar capire bene dove ci voglia portare; e giù pessime dizioni, incomprensibili fonemi ci conducono fino alla fine di un delirio che di Vate in Vate ci fa pure tenerezza. Poverina, vien da pensare, come mai si sarebbe potuto pensare di poter un giorno pensare della D U S E. Il paradiso delle scansioni. C’era una volta Martin Eden. Fonè perdonaci tu.
