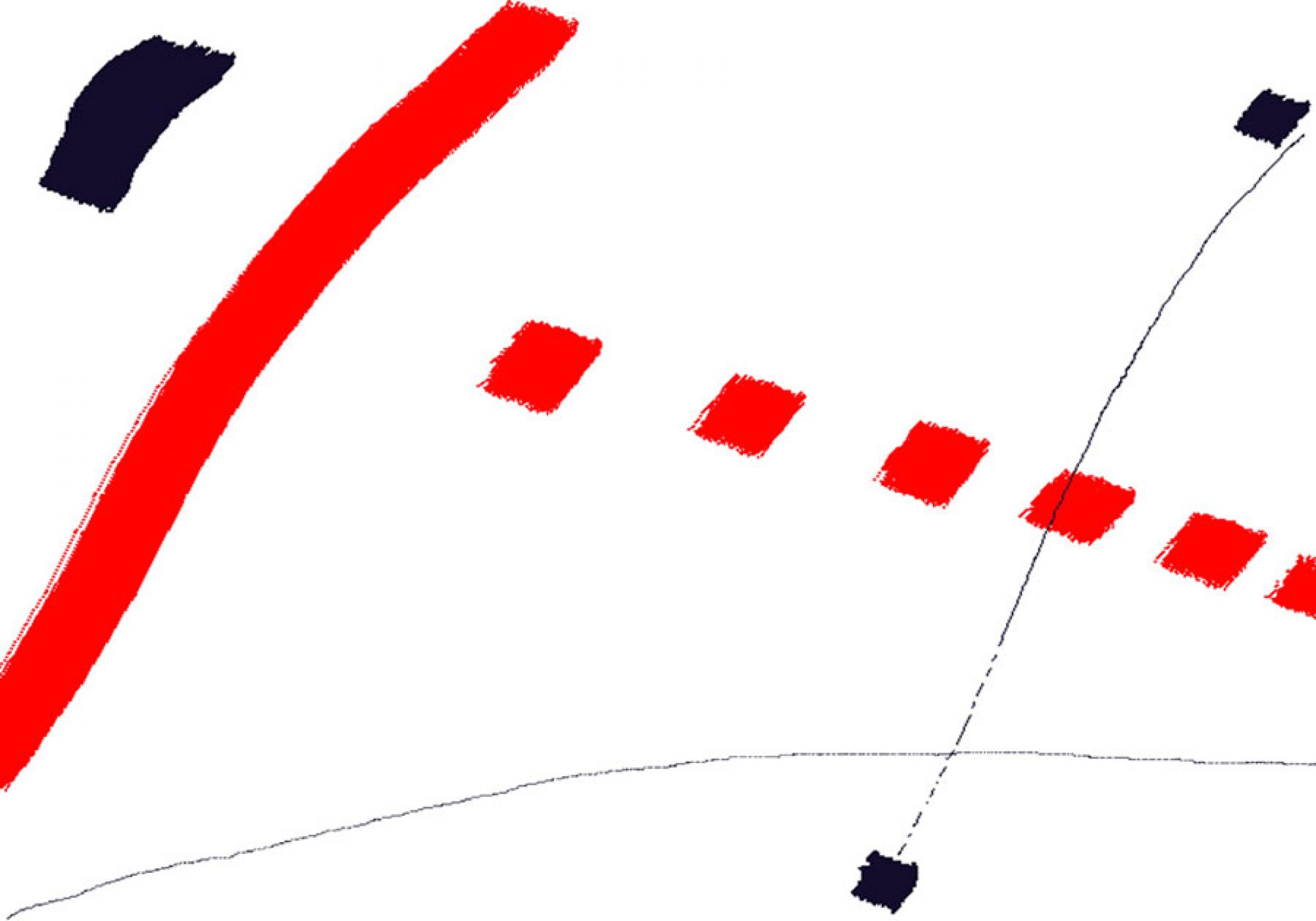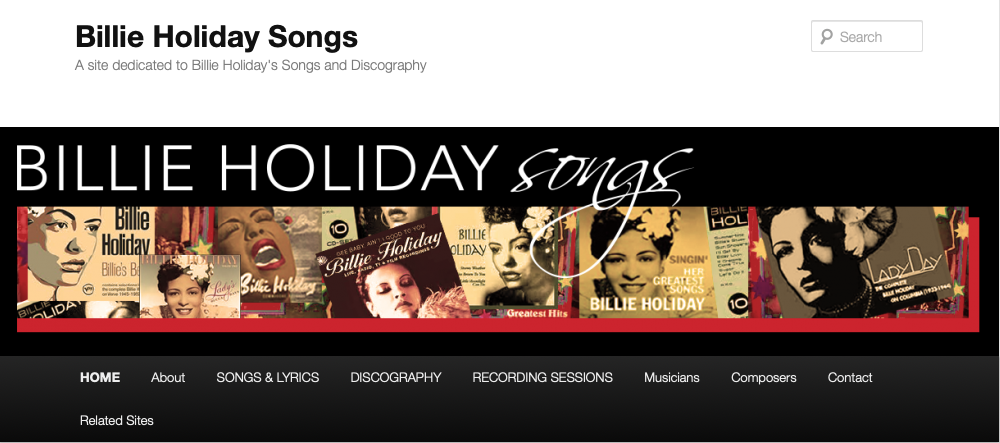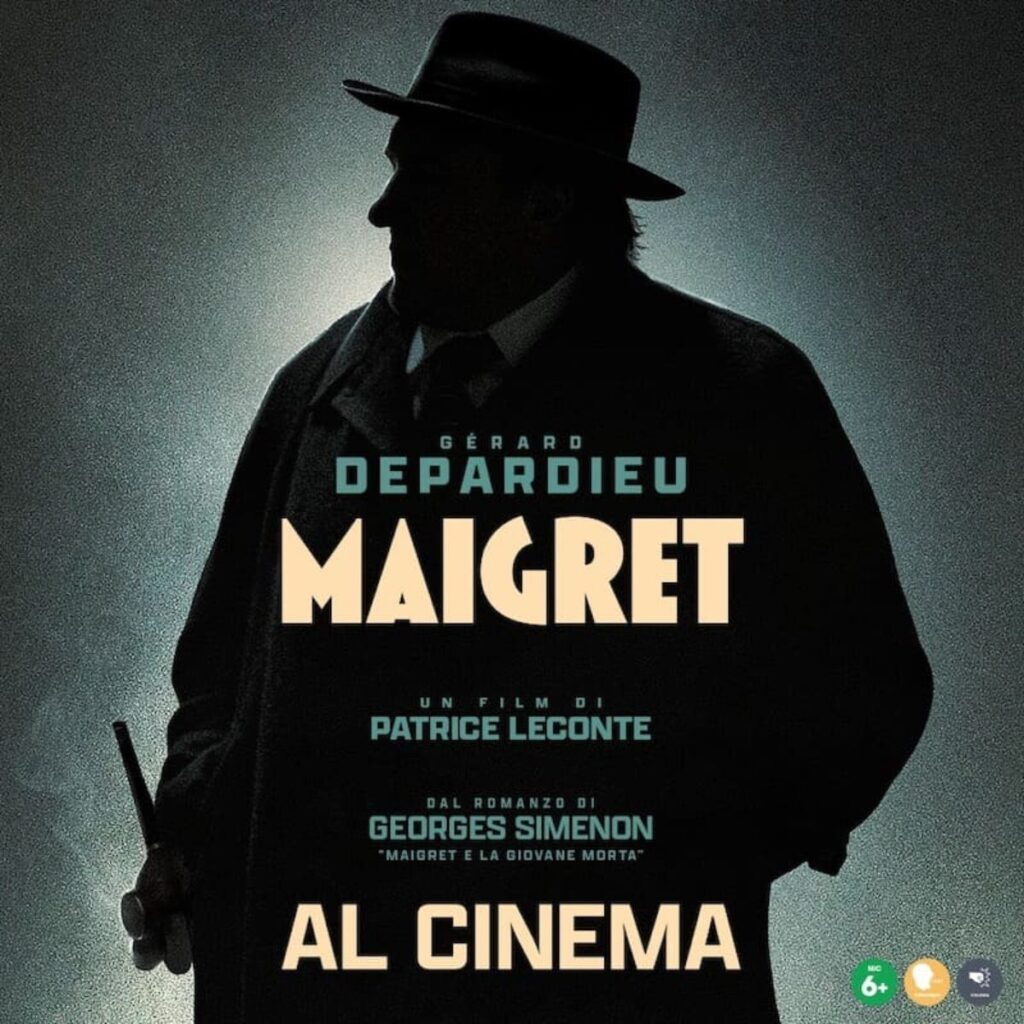La strada del riscatto è costellata di Millenni cui rimediare. La Storia giocando a campana?

Ormai si ricava una professione femminista anche dallo smaltimento della rapa neozelandese. Giusto, la strada del riscatto è costellata di millenni cui rimediare. L’isola di Pasqua sarà in futuro la culla storica della rumba e Abbe Lane una sacerdotessa Inca, pronipote della rapper Rapa Nui, ava della Cantatrice Calva, che nel 1475 introdusse l’uso della marimba nelle formazioni sinfoniche della Colombia precolombiana. E non sarà assolutamente difficile che la parabola-metafora-playstation-newhistorical riesca a passare come un accertato evento storico per una ormai larghissima fascia di consumatori della schiera ‘viva il cinema abbasso la storia’ ampiamente foraggiati da Ridley Scott, tra i molti altri; consumatori comodamente disabituati ad ogni riferimento e realtà autenticamente storici o almeno prepotentemente storicizzati nei secoli. Ciò tenendo tuttavia conto di che la domanda che sovente si è levata, qua e là, de vez en cuando, un po’ flamencorock un po’ mazurka, dal Manzanarre al Reno, è ‘Ma la Storia che Storia è?’. Le Goff, morto così giovane, considerando le durate minime che abbiamo ormai raggiunto e che, per poi trascurarci ad ogni sopravvivenza impostaci da non si sa quale etica assolutamente contro-aziendale, per poi un giorno trattarci come pacchi in qualche ospizio, vogliono portare alla durata di una quasi eternità, farà ancora in tempo a rivoltarsi nella tomba, se non è stato cremato? O vedrà scorrere, stavolta nello splendore del digitale formato 16:9, minuto per minuto, come nella moviola di un montatore di bibbie playstation newfantasy, le tribolazioni degli storici in crisi che girano chiese e mercati ubriacandosi per dimenticare umiliazioni e patimenti a causa di nobili adultere che hanno infuocato le loro epoche d’oro sottratte a sane formazioni who’s who e turbato i loro successivi sogni influenzali. Glorious! Un copione presto a venire. Una storia senza uguali. Perché è ancora tutta da inventare. Perché deve ancora accadere. Che sgorgherà, di antichissima contemporaneità, hic et nunc, per qualcuno dei quasi tutti per i quali la storia nasce esclusivamente con e dal giorno della propria nascita, tutto il resto non è mai esistito. Prima: A) avverbio di improbabliità B) Sinonimo di inesistenza. L’hic et nunc, incontestabile attestato storico tanto comunemente e sentitamente avvertito come ricapitolazione dell’eternità che si può contestualizzare, rappresentare, raccontare, come più ci piace, mentre più si giace, anzi, se tra una cotoletta e l’altra e un passami il sale eccoti l’olio decidiamo di crederci, mentre tanti giacciono sotto macerie televisive. Ma sarà vero? Per blu, je m’en fou. Viva la foto perfetta! Gloria al pretesto. E Gloria sia!